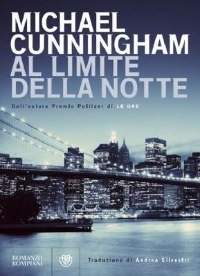Rileggere lo stesso libro dopo anni porta ad esiti discordati: se ci è piaciuto fin dall’inizio allora magari scopriremo dei dettagli che ce lo faranno amare ancora di più oppure non ritroveremo proprio quelle piccolezze che ce l’avevano fatto apprezzar e delusi arriveremo alla conclusione che si cambia mentre i libri rimangono gli stessi; se non ci è piaciuto allora c’è la possibilità di rivalutarlo in chiave positiva oppure abbandonarlo sull’apposito scaffale dedicato ai libri che a tutti piacciono e a me no ( nel mio trovate Anna Frank, che non sono mai riuscita a finire. Shame on me.). La rivalutazione è forse uno degli aspetti più interessanti della rilettura perchè sottolinea il cambiamento che avviene in una persona e la stretta correlazione tra il momento della lettura e la realtà psicologica del lettore, oltre al fatto che spesso la scelta di un romanzo è completamente casuale e quindi potrebbe accordarsi allo stato d’animo del lettore come opporsi e spingerlo a reagire. (La magia dei libri, se ne parlerebbe per ore.)

L’autore mentre si gratta
Tornando a noi, questa riflessione scaturisce dalla rilettura di un romanzo su cui avevo avuto tante aspettative al momento della prima lettura perchè scritto da uno dei miei scrittori preferiti ovvero Jonathan Safran Foer, entrato di prepotenza nella mia classifica del cuore grazie a Molto forte, incredibilmente vicino, suo secondo romanzo. Ricordo che avevo particolarmente amato la disperata ricerca newyorkese di Oskar, la caratterizzazione di personaggi e la capacità dello scrittore di rendere il profondo disagio psicologico che si riversa su un bambino al momento della morte di un famigliare grazie a dei piccoli dettagli che agli occhi di un lettore distratto sarebbero sfuggiti, lasciandolo orfano di uno dei piaceri più grandi della prosa di Foer: la sensibilità e il dolore racchiusi nei piccoli gesti che sono più grandi di qualsiasi reazione disperata, grida e pianti. Inoltre, ero rimasta profondamente affascinata dalla quantità di neologismi inseriti come parole assolutamente comuni nel corso della narrazione, risultati della genialità del piccolo Oskar e del suo buffo carattere. Tra quei neologismi c’è il verbo scucciolare, che uso con orgoglio ancora oggi nell’accezione di fare le coccole (”Posso scucciolare il tuo cane?”). Questa manipolazione linguistica che ha arricchisce la personalità del protagonista conferendogli una nota di stranezza mi ha ricordato il padre di Natalia Ginzgburg in Lessico Famigliare ed i suoi insulti fantasiosi ( Non fate sbrodeghezzi! Non fate potacci!).

Ora capite perchè lo amo.
Contentissima di sapere che Foer aveva scritto un altro romanzo prima delle avventure di Oskar, mi sono lanciata nella lettura con un mare di aspettative, una più alta dell’altra: mi aspettavo tutte le cose che avevo già visto in Molto Forte ma in chiave leggermente diversa, sì, ma non troppo diversa, mi raccomando, ti prego non mi deludere, ok Jonathan? E invece Johnny mi aveva deluso profondamente. Il tema era lo stesso: una ricerca impossibile, dei compagni di viaggio bizzarri e un sarcasmo che mascherava una tristezza sotterranea. Peccato che gli sbalzi temporali mi sono subito sembrati troppo improvvisi, la trama principale e quella secondaria poco interessanti e scollegate tra loro, l’operazione linguistica troppo intensa. Insomma, ne rimasi delusa e lo lessi col broncio. Col broncio, fino alla fine, ma senza capire nulla.
 Ho ripreso in mano il romanzo una settimana fa, spinta dalla quantità immensa di recensioni entusiaste che leggevo sul web ormai da anni, rassegnata alla convinzione che il non sei tu, sono io funziona anche con i romanzi (Soprattutto con i romanzi. Di solito sei tu e basta.) Mi sono impegnata questa volta, liberandomi da tutte le aspettative e pronta a deporre il romanzo al fianco della mia ormai sconsolata e solitaria copia di Anna Frank sullo scaffale maledetto dal mio personalissimo gusto letterario. E invece l’ho rivalutato come Standard & Poor’s rivaluta i paesi emergenti da uno sconsolante B- ad un glorioso AA+. Perchè il problema ero io, insomma. Il problema erano le mie aspettative che non volevano altro che rileggere lo stesso romanzo che avevo amato con una copertina diversa. Invece, Ogni cosa è illuminata ha un’anima completamente diversa da quella di Molto forte, incredibilmente vicino. E’ un romanzo epistolare, una fantasiosa ricostruzione storica, un’antologia di storie d’amore condita da picchi di sarcasmo e depressioni liriche in cui la voce dell’autore fantastica sulle avventure dei suoi antenati, inventando un albero genealogico molto bizzarro e quella di Alexander detto Sasha, guida turistica dell’improvvisato viaggio di Safran in Ucraina che si occupa di ricostruire il loro viaggio. L’aspetto più divertente e innovativo del romanzo è l’ennesima operazione linguistica, ancora più straordinaria dei neologismi infantili di Oskar: l’intera parte epistolare del romanzo, scritta da Alexander, è resa nel suo inglese sgrammaticato da studente ucraino di prima classe. Quella che a prima vista potrebbe sembrare una traduzione all’altezza del traduttore automatico di Google è in realtà una delle parti più interessanti e divertenti del romanzo. Si tratta di una vera e propria sfida per il lettore che deve cercare di andare oltre il significato letterale delle parole e sostituire a vocaboli inventati, antichi o completamente sbagliati le loro versioni corrette o attuali. Alcuni esempi:
Ho ripreso in mano il romanzo una settimana fa, spinta dalla quantità immensa di recensioni entusiaste che leggevo sul web ormai da anni, rassegnata alla convinzione che il non sei tu, sono io funziona anche con i romanzi (Soprattutto con i romanzi. Di solito sei tu e basta.) Mi sono impegnata questa volta, liberandomi da tutte le aspettative e pronta a deporre il romanzo al fianco della mia ormai sconsolata e solitaria copia di Anna Frank sullo scaffale maledetto dal mio personalissimo gusto letterario. E invece l’ho rivalutato come Standard & Poor’s rivaluta i paesi emergenti da uno sconsolante B- ad un glorioso AA+. Perchè il problema ero io, insomma. Il problema erano le mie aspettative che non volevano altro che rileggere lo stesso romanzo che avevo amato con una copertina diversa. Invece, Ogni cosa è illuminata ha un’anima completamente diversa da quella di Molto forte, incredibilmente vicino. E’ un romanzo epistolare, una fantasiosa ricostruzione storica, un’antologia di storie d’amore condita da picchi di sarcasmo e depressioni liriche in cui la voce dell’autore fantastica sulle avventure dei suoi antenati, inventando un albero genealogico molto bizzarro e quella di Alexander detto Sasha, guida turistica dell’improvvisato viaggio di Safran in Ucraina che si occupa di ricostruire il loro viaggio. L’aspetto più divertente e innovativo del romanzo è l’ennesima operazione linguistica, ancora più straordinaria dei neologismi infantili di Oskar: l’intera parte epistolare del romanzo, scritta da Alexander, è resa nel suo inglese sgrammaticato da studente ucraino di prima classe. Quella che a prima vista potrebbe sembrare una traduzione all’altezza del traduttore automatico di Google è in realtà una delle parti più interessanti e divertenti del romanzo. Si tratta di una vera e propria sfida per il lettore che deve cercare di andare oltre il significato letterale delle parole e sostituire a vocaboli inventati, antichi o completamente sbagliati le loro versioni corrette o attuali. Alcuni esempi:
un uomo inseminativo = un uomo virile
avere requiem = riposare
fabbricare le Z = dormire
bussarsi il petto = essere profondamente dispiaciuti, scusarsi
sfagiolare qualcuno/qualcosa = adorare, amare alla follia ma platonicamente
ogni cosa è illuminata = ogni cosa è chiara, ho capito tutto
Un altro aspetto divertente del romanzo è la satira degli ebrei. Foer fa risalire la nascita del suo primo antenato conoscibile al 1791, quando un carro trainato da un cavallo imbizzarrito cade nel letto del fiume Brod e tra i resti della carrozza e dei suoi bagagli appare una bambina appena nata. La notizia scuote lo shtetl, la comunità ebraica, che si appresta a scrivere l’avvenuto sull’infinito Libro degli antecedenti e ad affidare la bambina alle cure dell’ex-usuraio Yankel. Il sarcasmo di Foer, ebreo anch’egli, è messo sul vittimismo storico degli ebrei, dalla loro disorganizzazione che provoca pasticci e malintesi e sulle loro usanze antiche ma paradossali. Ecco un estratto dal Libro degli antecedenti:
IL MULINO
Fu così che nell’undicesimo anno di un secolo da molto trascorso, il Popolo Eletto (cioè noi) fu guidato fuori dall’Egitto dal nostro capo, allora-saggio Mosè.Nella fretta della fuga non bastò il tempo per far lievitare il pane e Iddio nostro Signore, possa il Suo nome ispirare lieti pensieri, il Quale, nel cercare la perfezione in ogni Sua creatura, non voleva un pane imperfetto, disse al Suo Popolo (noi, non loro): NON SFORNATE ALCUN PANE CHE SIA SECCOM SCIPITO, DI CATTIVO SAPORE O CAUSA DI DISPERATA COSTIPAZIONE. Ma il Popolo Eletto aveva molta fame, e ci provammo con un po’ di buon lievito. Quel che fu sfornato da parte nostra fu meno che perfetto, anzi per vero dire secco, scipito, di cattivo gusto e causa di molte merdose ritenzioni, e Iddio, possa il suo nome abitare sempre le nostre non screpolate labbra, si arrabbiò molto. E’ a causa di questo peccato dei nostri avi che un membro dello shtetl è rimasto ucciso nel mulino ogni anno, dalla sua fondazione del 1713.
Ma tra una sinagoga ambulante e un sacco di personaggi buffi, il romanzo mostra anche il suo lato serio riportando alla luce la strage nazista in Ucraina, lasciando da parte le ricostruzioni storiche fantasiose e tornando alla cruda realtà. Gli ebrei venivano chiusi nelle sinagoghe alle quali veniva dato fuoco oppure obbligati a fornire il nome di un ebreo della comunità, pena la fucilazione immediata. Così come in Molto forte, incredibilmente vicino era stato affrontato il bombardamento di Dresda, Foer attinge dalla storia contemporanea per controbilanciare la sua sfrenata immaginazione con la dura realtà storica.
E il Generale ha sparato a mia sorella. Io non riuscivo a guardarla, ma ricordo il rumore quando è caduta per terra. Ancora sento quel rumore quando le cose cadono a terra. Tutte le cose.
Tornano, in ordine sparso, tutte le peculiarità dello stile di Foer, inclusa la meravigliosa caratterizzazione dei personaggi: Alexander è un finto spaccone che aspira a fare il commercialista in America per salvare suo fratello dalla violenza del padre, Yankel è un vecchio deluso dall’amore e dalla vita che rinasce e muore in pace grazie a Brod, la capostipite dell’immaginaria famiglia di Safran, uno dei personaggi migliori del romanzo a mio parere.
Brod scoprì seicentotredici tristezze, ciascuna assolutamente unica, ciascuna una singola emozione, non più simile a qualunque altra tristezza di quanto fosse simile all’ira, all’estasi, ai sensi di colpa e alla frustrazione. Tristezza dello Specchio. Tristezza degli Uccelli Addomesticati. Tristezza di Esser Triste di fronte a un Genitore. Tristezza dell’Umorismo. Tristezza dell’Amore senza Scioglimento.
E poi ci sono Safran, lo storpio che diventa un Don Giovanni tra le vedove dello shtetl alla precoce età di dieci anni grazie alla sua mano morta (lo stesso fascino derelitto di Florentino Ariza di L’amore ai tempi del colera) e la sua ultima amante, la Zingarella, e la sua nuova sposa, Zasha. E come dimenticare la pestifera cagna Sammy Davis Junior Junior, violenta compagna di viaggio di Jonathan, Alexander e Nonno Alexander affetto da una cecità psicosomatica che non gli impedisce di guidare l’auto per conto del figlio, gestore dei Viaggi Tradizione, la sfortunata compagnia di viaggi che Jonathan sceglie per rintracciare la donna che salvò suo nonno dai nazisti. Una carrellata di personaggi indimenticabili, situazioni spassose ed altre agghiaccianti, una doppia trama profondamente complessa in un romanzo che non dovete sottovalutare. L’ho già atto io per voi, e avete visto com’è andata a finire: avevo torto marcio.
(Ora mi tocca rileggere anche quella palla al piede di Anna Frank. Non ce la posso fare).
Nella seconda parte di Ogni cosa è illuminata analizzerò la versione cinematografica realizzata nel 2005 con Elijah Wood. Stay tuned!





 Ironia a parte, Penelope incarna seriamente un modello comportamentale femminile che oggigiorno oserei definire controproducente e obsoleto. Per evitare allora che Simone de Beauvoir e Katherine Pankhurst si rivoltino nella tomba alla sola idea che nel 2016 vi siano ancora donne che facciano ancora la tela a casa (e quest’espressione racchiude ogni occasione nella quale una donna desidera vivere una vita attiva e qualcosa o qualcuno glielo impedisce), è necessario portare alla luce delle personalità-guida che, seppur fittizie, sappiano bilanciare questo lato ancestrale della femminilità con degli esempi più indipendenti e coraggiosi. La libertà è femmina, e la controversia pure.
Ironia a parte, Penelope incarna seriamente un modello comportamentale femminile che oggigiorno oserei definire controproducente e obsoleto. Per evitare allora che Simone de Beauvoir e Katherine Pankhurst si rivoltino nella tomba alla sola idea che nel 2016 vi siano ancora donne che facciano ancora la tela a casa (e quest’espressione racchiude ogni occasione nella quale una donna desidera vivere una vita attiva e qualcosa o qualcuno glielo impedisce), è necessario portare alla luce delle personalità-guida che, seppur fittizie, sappiano bilanciare questo lato ancestrale della femminilità con degli esempi più indipendenti e coraggiosi. La libertà è femmina, e la controversia pure.